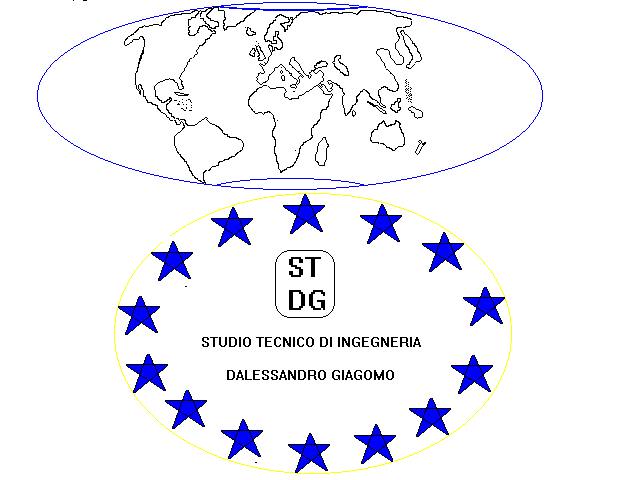|
il SOLE 24 ORE
per l'articolo completo vai al sito Internet
http://www.ilsole24ore.com
2009-06-14
Basta con la crisi è l'ora della ripresa
di Renato Brunetta
13 giugno 2009
ANIMAZIONE / La crisi della finanza e dell'economia, dai mutui subprime ai disoccupati
Gli analisti in tutto il mondo s'interrogano sui tempi della ripresa. La recessione sta decelerando? Siamo vicini alla risalita? Le risposte non sono omogenee e soprattutto sono molto volatili. I governi si pongono le stesse domande. Ma, a differenza degli analisti, i governi sono chiamati a influire su queste previsioni e quindi a dare risposte condizionate, cioè in parte dipendenti dalle politiche messe in atto. In parte, perché l'effettiva capacità dei governi d'influire sulla crescita economica è scarsa, soprattutto per quella di lungo periodo.
È maggiore la capacità d'influenzare la congiuntura, soprattutto se essa è di tipo asimmetrico, se cioè colpisce un singolo paese o un'area del mondo. Ma è limitata se la recessione è globale, come nel caso che stiamo vivendo, e se, com'è il caso dell'Italia, il paese è una piccola economia aperta, fortemente integrata nei mercati internazionali. Non si tratta di una premessa per l'inazione della politica, ma al contrario per una lettura oggettiva dei dati della recessione al fine di condizionarne, per quanto possibile, l'evoluzione futura con politiche appropriate.
I dati, anche quelli appena forniti dall'Istat relativi al primo trimestre dell'anno in corso sul Pil e le sue componenti di domanda, ci dicono che la recessione è grave, ma è nell'ordine delle recessioni conosciute negli anni 70. I dati confermano che l'Italia sta subendo l'impatto della crisi mondiale attraverso due canali principali: il collasso del commercio internazionale e la crisi finanziaria che ha determinato un restringimento del credito. Questo impatto si legge, nei dati congiunturali italiani, nella caduta delle esportazioni, conseguenza del crollo della domanda mondiale, e nella forte flessione degli investimenti, scoraggiati dall'incertezza sulla domanda futura e frenati dalle difficoltà di finanziamento. Nei dati si legge anche l'effetto del ciclo delle scorte che accentua la flessione della produzione nelle fasi di riduzione della domanda.
I governi, presi singolarmente, possono cercare d'influenzare la domanda interna, cioè i consumi e investimenti interni, non quella estera. I consumi delle famiglie sono certamente diminuiti, ma in misura limitata tenuto conto dell'ampiezza della recessione. Negli ultimi tre trimestri di recessione essi hanno contribuito per meno di un quarto alla flessione del Pil, pur rappresentando la componente di maggior peso della domanda interna. La relativa tenuta dei consumi è spiegata dal fatto che i cosiddetti redditi fissi, cioè i redditi rappresentati da salari e pensioni, non sono colpiti dalla crisi, ma sono previsti al contrario crescere in termini reali grazie alla flessione del tasso d'inflazione.
Evidentemente sono colpiti dalla crisi, tra i lavoratori dipendenti, coloro che perdono il lavoro e coloro che usufruiscono della cassa integrazione. Gli stanziamenti del governo per il sostegno di questi redditi sono stati fondamentali, non solo per un dovere sociale inderogabile dello Stato, ma per impedire la caduta della propensione al consumo. Se questa caduta non c'è stata è perché, di fatto, si sono ridotti, a causa della recessione, gli altri redditi, che sono principalmente i redditi da lavoro autonomo e altri redditi vari da capitale. È difficile dire quanti dei percettori di questi redditi siano soggetti a vincoli di liquidità, cioè non siano in grado di mantenere inalterati i propri consumi di fronte a una flessione temporanea dei propri redditi, anche perché gran parte delle famiglie percepisce contemporaneamente redditi di vario tipo. Tuttavia è certo che per una parte non trascurabile di essi è possibile non ridurre i consumi proporzionalmente. Non lo è invece per molte altre fasce di lavoro autonomo, più deboli, soprattutto per i tanti giovani e meno giovani che lavorano con contratti temporanei.
Ma, si è detto, il governo è tenuto a far seguire l'azione alle analisi dei fatti. Fino ad oggi esso ha compiuto il suo dovere sui due fronti principali di impatto alla crisi. Ha stanziato fondi sufficienti a garantire sicurezza ai redditi di quei lavoratori dipendenti che vengono colpiti dalla flessione produttiva. Al tempo stesso, e come prima azione, ha offerto il sostegno necessario al sistema bancario italiano per superare difficoltà temporanee e garantire il risparmio degli italiani, bloccando così l'insorgere di situazioni di panico. Siamo ora entrati in una fase cruciale in cui si tratta di sostenere l'attività produttiva e la domanda interna per tre o quattro trimestri in attesa che riparta il ciclo mondiale.
Ciò è necessario per tre motivi connessi tra loro. Il primo è che occorre impedire che cresca il costo sociale ed economico rappresentato dalla perdita di posti di lavoro o dalla riduzione delle ore lavorate. È preferibile, per quanto possibile, usare le risorse per creare o mantenere posti di lavoro che per sostenere i redditi di chi perde il lavoro, e questa strategia sarebbe favorita qualora si confermasse una dinamica dell'assorbimento di risorse per gli ammortizzatori sociali inferiore a quanto, per sicurezza, stanziato dal governo. Il secondo è che è necessario mantenere e rafforzare la capacità produttiva per poter cogliere la fase di ripresa. Il terzo è che bisogna stabilizzare gli altri redditi non da lavoro dipendente colpiti fortemente dalla crisi, soprattutto quelli delle fasce più deboli, e impedire che aumentino le difficoltà di accesso al lavoro per le nuove generazioni.
Che fare quindi? Coniugare un'azione congiunta dal lato della domanda e dell'offerta. Dal lato della domanda, nell'ambito dei vincoli di bilancio, le risorse devono essere concentrate nella domanda pubblica di infrastrutture, di nuove tecnologie, di manutenzione del capitale pubblico e nell'incentivazione, spesso possibile a costo quasi nullo, della spesa privata nella stessa direzione (piano casa, manutenzione del capitale fisico privato, tecnologie verdi e digitali). Quest'azione può essere favorita sia da una maggiore efficienza della Pa nei suoi pagamenti al settore privato sia da un'attenta ricomposizione della spesa pubblica che allenti, nel rispetto dell'obiettivo generale di deficit pubblico, i vincoli di bilancio cui sono sottoposti gli enti locali nell'attuazione dei propri progetti di investimento.
Dal lato dell'offerta è necessario aumentare l'azione sul sistema bancario perché non faccia mancare il credito di sostegno all'attività produttiva e agli investimenti privati, cruciali non solo per il sostegno della domanda interna ma anche per mantenere e adeguare la capacità produttiva affinché risponda alla ripresa della domanda. Oggi non manca il risparmio, è necessario rimetterlo in circolo.
L'autore è ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione
13 giugno 2009
La rivincita degli stati e della politica
di Giulio Napolitano
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
13 giugno 2009
La crisi, almeno in apparenza, segna una parziale rivincita degli stati sulla globalizzazione, della politica sulla tecnica, dei giuristi sugli economisti. Ma la rivincita deve essere gestita in modo intelligente se si vogliono evitare gli abbagli e porre le basi per una seria riforma della regolamentazione, in grado di prevenire nuove crisi sistemiche in futuro.
La prima rivincita è quella degli stati, sia nei confronti dei processi di globalizzazione, sia nei riguardi delle organizzazioni internazionali. Di fronte all'esplosione della crisi, soltanto gli stati nazionali si sono dimostrati in grado di adottare tempestivamente i necessari interventi di salvataggio nei confronti di banche e intermediari finanziari e di rassicurare così investitori e risparmiatori. Alcuni stati, poi, hanno preferito adottare comportamenti opportunistici: ad esempio, cercando di scaricare sui paesi vicini gli effetti della crisi o ricorrendo a misure protezionistiche. Altri, come quelli dell'eurogruppo, hanno riconosciuto l'importanza di risposte sì nazionali, ma almeno coordinate a livello continentale. I più lungimiranti, come la Germania e l'Italia, hanno insistito sulla necessità di nuove regole internazionali per l'economia e per la finanza. La definizione di global standard, in questa prospettiva, può servire a colmare gravi lacune regolamentari e a impedire che la concorrenza tra ordinamenti dia luogo a una corsa al ribasso, capace di travolgere qualsiasi valore e tutela.
Anche i paesi più coraggiosi nella ricerca di nuove regole a livello globale, tuttavia, tendono a privilegiare il metodo intergovernativo, basato su accordi tra stati che rimangono pienamente sovrani. Ma, in questo modo, la riforma della regolamentazione e la sua concreta attuazione rischiano di rimanere ostaggio del potere di veto e delle convenienze di ciascun paese. A ciò si aggiunge il pericoloso indebolimento delle istituzioni sovranazionali, a cominciare dalla Commissione europea, che in passato hanno ben garantito il rispetto delle regole comuni, sanzionando severamente le violazioni delle imprese e degli stati.
La seconda rivincita è della politica sulla tecnica. La crisi, soprattutto negli Stati Uniti, ha messo a dura prova la credibilità delle autorità di vigilanza, mentre sono stati gli organi elettivi a farsi carico degli indispensabili interventi di salvataggio. Sarebbe però sbagliato pensare che la soluzione di ogni problema sia politica. Naturalmente, spetta ai rappresentanti dei cittadini indicare fini e valori in cui la comunità s'identifica e che il diritto, con le sue istituzioni, deve garantire. Così come compete ai parlamenti e ai governi adottare le scelte di politica economica e industriale ritenute meglio rispondenti all'interesse nazionale. Ma assicurare il buon funzionamento dei mercati e tutelare utenti e consumatori deve rimanere funzione propria delle autorità di vigilanza, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario e globale.
Per questa ragione, una delle principali preoccupazioni dei policy makers dovrebbe essere quella di tutelare l'indipendenza delle autorità, sia dalla cattura dei privati, sia dai condizionamenti distorsivi della politica; di estendere e rendere più incisivi i loro poteri di regolazione, controllo e sanzione; di rendere più trasparente e accountable il processo decisionale; di ridurre frammentazioni o sovrapposizioni di competenze, facilitando lo scambio d'informazioni e la capacità d'intervento coordinato.
La terza rivincita è dei giuristi sugli economisti. La crisi, infatti, ha travolto anche la pretesa di alcune scuole economiche di dettare l'agenda delle istituzioni politiche e dei regolatori, come se il diritto dovesse limitarsi a liberare le positive forze del mercato. I giuristi, però, rischiano di tornare vittime di vecchi miti, come quello della prescrittività del diritto o quello della purezza del metodo giuridico. Si può certo criticare da un punto di vista etico la trasformazione del diritto in una merce. Emblematica, in tal senso, sarebbe la rilettura offerta dagli economisti del cartello "sosta vietata": non più nel senso giuridico di "non parcheggiare qui il tuo veicolo", ma in quello economico di "parcheggia pure qui se sei disposto a pagare la multa per divieto di sosta".
Porterebbe però davvero "fuori strada" pensare che basti gridare a gran voce il divieto o inasprire le sanzioni scritte nei codici per avere di nuovo corsie e passaggi non ostruiti da automobilisti opportunisti.
Analogamente, soltanto un insolito impasto di romanticismo e amor di bottega può arrivare a vedere nei "notai latini" i controllori più sperimentati degli animal spirits dell'economia. Nessuno naturalmente vuole negare il positivo contributo che le professioni legali possono dare allo svolgimento delle transazioni di mercato, ma la prevenzione e la correzione dei suoi fallimenti richiedono istituzioni terze e indipendenti piuttosto che pur sapienti consulenti, peraltro remunerati dalle stesse parti in causa. La lezione di realismo impartita dal metodo interdisciplinare della Law and Economics, allora, appare ancora oggi indispensabile, se si vogliono introdurre nuove regole che siano non meramente declamatorie, ma davvero in grado d'orientare i comportamenti degli attori economici e di tutelare beni e valori collettivi.
gnapolitano@uniroma3.it
L'autore è professore ordinario di diritto pubblico
all'Università Roma Tre
13 giugno 200
L'inflazione? Non è il male peggiore
di Carlo De Benedetti
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
12 giugno 2009
ANIMAZIONE / La crisi della finanza e dell'economia, dai mutui subprime ai disoccupati
"Un po' d'inflazione controllata in questa fase sarebbe più che utile". Lo ha detto Jacques Delors qualche settimana fa presentando il suo ultimo libro Investir dans le social, dove emerge un ruolo nuovo dello stato in economia, concentrato soprattutto nel rafforzare quelle che Amartya Sen definirebbe capabilities dell'individuo, sin dall'infanzia. Mi ha colpito la sua insistenza sul tema dell'inflazione come strumento utile ad uscire dalla crisi e sulla necessità di una relazione più stretta, che anch'io da tempo sostengo, tra politiche monetarie ed economiche.
Qualche settimana fa il New York Times citava un cantante country western americano, Merle Hazard, come colui che meglio di chiunque altro ha evidenziato, in questi mesi, il dilemma che abbiamo davanti: "Inflation or deflation - canticchia Merle - tell me if you can: will we become Zimbabwe or will we be Japan?". Esiste davvero questo Merle. Lo sono andato a scovare su YouTube. Basta mettere il suo nome su Google. Un personaggio stralunato, con tanto di cappellone da cowboy, e accompagnato da un certo Bretton Wood. Va avanti per due minuti e mezzo, rivolgendosi a un certo punto anche a John Maynard Keynes: "Dimmi John, i dollari nel mio taschino compreranno di più o di meno il prossimo anno?". Straordinario. Secondo me dietro quel tipo si nasconde un economista raffinato. Perché è proprio intorno a quest'ultima domanda che oggi ci giochiamo l'uscita dalla crisi.
Per alcuni la crisi ha indubbiamente determinato una riduzione del reddito disponibile. Sono coloro che hanno subìto in famiglia licenziamenti o che hanno comunque dovuto affrontare un taglio della retribuzione. Ma per molti altri i salari hanno mantenuto una dinamica assolutamente normale. Anzi, la contrazione in taluni prezzi ha di fatto aumentato il loro potere d'acquisto. Perché allora queste persone non comprano come potrebbero? La risposta è nel gioco cruciale delle aspettative. Per l'appunto in quel dilemma: "Dimmi John, i dollari nel mio taschino compreranno di più o di meno il prossimo anno?". Ebbene, fino a quando l'aspettativa sarà che quei dollari compreranno di più, perché i prezzi caleranno, l'avvitamento della crisi nella deflazione farà peggiorare la situazione giorno dopo giorno. Più le persone rinvieranno gli acquisti, più i prezzi caleranno, più i debiti contratti - soprattutto nell'acquisto delle case - peseranno sui potenziali consumatori.
È una realtà che le autorità monetarie, preoccupate per decenni soprattutto dell'inflazione, non comprendono in tutta la reale portata. Certo, soprattutto in America, Regno Unito, Giappone e Svizzera le banche centrali hanno abbassato i tassi d'interesse a breve vicino allo zero. Ma non c'è ancora quel messaggio chiaro ed esplicito che aiuterebbe a invertire le aspettative: la deflazione - ecco il messaggio da far passare - è il nostro nemico e per combatterlo siamo pronti a quello che gli americani chiamano un reflationary shock. Ce lo insegnano le grandi crisi del passato, e le strategie attuate per il loro superamento. Ci insegnano quanto la deflazione possa essere dannosa e quanto serva uno shock inflazionistico per porre fine alle aspettative deflattive e rilanciare la crescita.
Dal '29 al '33 i prezzi, a causa della deflazione, calarono del 27 per cento. Poi un contributo decisivo per superare la Grande Depressione venne dalla decisione dell'amministrazione Roosevelt di aumentare tra il '33 e il '34 il prezzo dell'oro fino a 35 dollari per oncia. Questa mossa portò a una svalutazione della moneta americana e a un aumento dei prezzi di tutti i generi - in particolare quelli agricoli - che diede una spinta straordinaria per rendere i debiti meno onerosi e far riprendere l'economia. Qualcosa di analogo è avvenuto nel caso della depressione svedese del '92, quando un deprezzamento della moneta mise fine a un anno di pericoloso declino. Al contrario il Giappone, negli anni 90, ha trascinato la sua spirale depressiva anche perché la Banca nipponica, pur portando i tassi a zero, si è mossa con tale prudenza e riluttanza da non invertire le aspettative.
Qualche settimana fa l'economista americano Allan Meltzer, dicendosi preoccupato per l'inflazione, notava che "nessun paese, affrontando enormi disavanzi di bilancio, la rapida crescita dell'offerta monetaria e la prospettiva di una costante svalutazione, ha mai sperimentato la deflazione. Questi fattori - concludeva - sono messaggeri d'inflazione". Il Nobel Paul Krugman gli ha risposto con un semplice grafico sulla "decade perduta" del Giappone, che appunto evidenziava la tendenza deflazionistica in quelle condizioni. Lezioni dalla storia, appunto. Una lezione che dobbiamo saper ascoltare oggi che abbiamo di nuovo davanti quel dilemma: "inflazione o deflazione?".
L'errore compiuto allora dalle autorità monetarie giapponesi, lo ricordo bene, fu denunciato dai maggiori policy makers americani di oggi, a cominciare dal presidente della Fed Ben Bernanke e dal capo del Consiglio economico di Obama, Lawrence Summers. Eppure questi stessi uomini, oggi, non sembrano avere la necessaria determinazione nell'evitare quell'errore, trasmettendo all'economia la scossa inflazionistica che non è rinviabile. Quello shock permetterà di ridurre il peso dei debiti, che le tendenze deflazionistiche tendono invece ad accentuare con conseguenze perverse su tutto il sistema finanziario. E in secondo luogo invertirà il meccanismo delle aspettative dei consumatori, oggi paralizzati nelle loro scelte d'acquisto nella ragionevole attesa d'una ulteriore riduzione dei prezzi.
Capisco che chi, dagli anni 70, si è esercitato nella lotta all'inflazione, oggi abbia difficoltà a prendere le giuste misure a questa nuova realtà. E capisco che, quando si sono conosciuti i disastri dell'inflazione a due cifre, ci sia una grande prudenza nell'usare leve inflattive. Ma davanti allo scenario della deflazione, il rischio d'attivare un processo inflazionistico che possa sfuggire di mano è davvero un piccolo rischio che vale la pena correre.
La Fed e la Bce, perciò, e non solo loro, devono operare con determinazione per uscire dall'incertezza di chi si domanda "deflation or inflation" e assicurare con chiarezza che il prossimo anno il livello dei prezzi sarà ben più alto di quello di quest'anno. Serve una politica - anche della comunicazione - trasparente, attiva e sistematica in questa direzione. Va fissato un target per un livello d'inflazione tra il 2 e il 3% e va annunciato che non si permetterà che il tasso scenda sotto quella soglia.
Solo sapendo che i prezzi saliranno nell'ordine del 2-3% chi oggi è indebitato - soprattutto i proprietari di casa - potrà avere una ragionevole attesa che il peso di quell'onere possa in futuro diminuire (o almeno non aumentare) e nessuno avrà più interesse a rinviare i consumi, per il semplice fatto che l'aspettativa sarà di un prezzo più alto e non più basso. Questa è la priorità. I risparmiatori devono smetterla d'usare - come è stato detto - i propri soldi solo come uno sgabello per sedersi.
So bene che quest'approccio è esattamente quello che temono economisti come Meltzer. Loro credono che questo zelo anti-deflattivo renderà poi impossibile tenere sotto controllo l'inflazione. Ma, come ha osservato l'Economist, l'indicazione che ci viene dalle crisi del Novecento è che è più facile tenere sotto controllo l'inflazione che la deflazione. E comunque la prima fa meno danni della seconda. Non faremo la fine né del Giappone né dello Zimbabwe. Non la faremo perché il secolo scorso ci ha insegnato come fronteggiare la deflazione e perché quello stesso secolo ci ha insegnato come tenere sotto controllo l'inflazione. Il passato è la nostra salvezza. L'importante è saperne ascoltare la lezione.
L'articolo pubblicato è il testo dell'intervento che Carlo De Benedetti terrà oggi a Zurigo alla Camera di commercio italiana per la Svizzera
12 giugno 2009
"Pianificazione", parola di Giddens
di Leonardo Maisano
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
12 giugno 2009
Torna il pensiero lungo. La crisi del credito corre incontro a quella ambientale e segna la fine del pensiero corto che ha dominato l'ultimo trentennio sotto le spinte del riformismo radicale thatcheriano e reaganiano. L'incrociarsi del credit crunch con l'emergenza climatica finirà per accelerare una presa di coscienza collettiva che ancora manca. È una speranza quella di Anthony Giddens, distratto dalla Terza Via e concentrato sull'unica via che immagina dispiegarsi davanti all'umanità, quella della lotta contro il cambiamento del clima.
Il sociologo settantunenne, ex direttore della London School of Economics e oggi Pari del Regno, che ha scandito - con la Terza Via appunto - le linee guida del socialismo riformato adottato da Tony Blair, si dedica ora a mettere ordine nelle priorità che affollano la mente umana. Il paradosso di Giddens, che lui stesso illustra in questa chiacchierata e che analizza nel suo ultimo libro (The politics of climate change, Polity books), significa che la vera lezione per il futuro è trasformare quello che oggi è un retropensiero - la crisi climatica - nel pensiero dominante, senza attendere che sia troppo tardi.
È così ?
Sì, ma procediamo per gradi. Lezioni per il futuro, mi domanda. Bene, la priorità è tornare a politiche di lungo respiro per liberarsi dai retaggi della deregulation che poneva l'accento sui problemi da risolvere con una prospettiva a breve. Pensi a come sono state fatte le privatizzazioni in molti paesi. Hanno semplicemente spremuto quello che c'era da spremere senza fare investimenti a lungo termine, neppure dov'era indispensabile come nel settore energetico. Ora è necessario tornare alla pianificazione.
Una parola pericolosa in politica economica. In distonia netta con il New labour che lei ispirò a Tony Blair...
La Terza Via aveva un sottotitolo: il rinnovo della socialdemocrazia. Un concetto valido oggi come allora. Il New Labour si è ispirato ad esso e, come sempre in politica, ha anche compiuto errori determinati spesso dalle circostanze. Quando parlo di pianificazione, comunque, non mi riferisco al piano degli anni 60, ma mi appello all'elaborazione più sofisticata del concetto. In politica ambientale dobbiamo anticipare il prossimo ventennio, ma ora dobbiamo fare lo stesso nella più ampia accezione economico-finanziaria: in entrambi i casi si apre lo spazio per il ritorno della mano pubblica. L'uscita dalla recessione lo impone con maggior decisione. L'investimento in tecnologie moderne rappresenta il 18% dello stimolo fiscale di Obama, in Corea del Sud addirittura il 75 per cento. Il ruolo dello stato si afferma, dunque, ma questo non significa affatto stilare rigide previsioni per il futuro con scadenze pluriennali dominate dalla volontà del governo. Significa, certo, la fine della deregulation thatcheriana.
Anche lei si allinea con chi vede nel riformismo neoliberista degli anni 80 le origini di questa crisi e s'arruola con i fautori di politiche keynesiane?
Credo che all'origine della crisi ci siano anche le scelte thatcheriane e sono convinto che quell'epoca sia finita, ma non penso che Keynes possa convivere con il livello di globalizzazione raggiunto. Comincia un'era che va oltre queste categorizzazioni. Cambia un'epoca, ma non sappiamo in quale epoca stiamo entrando. Per questo si pone l'urgenza di un enorme sforzo di pensiero, sociologico, economico, politico. Pensiero laterale intendo, ad altissimo tasso di creatività. E manciate di utopia. Un processo che ci vedrà impegnati in proiezioni teoriche molto avanzate, seguite da un ritorno alla realtà odierna e a molte successive discussioni per decidere come arrivare dal presente a un obiettivo futuro. Sarà un'impresa faticosa immaginare il nuovo volto di un capitalismo responsabile. Intendo, ad esempio, un capitalismo che non misuri lo sviluppo solo in termini di Pil. Nelle società avanzate la crescita del Pil non si declina sempre con il welfare. Spesso va nella direzione opposta.
Il suo collega ai Lords ed ex cancelliere di Margaret Thatcher, Nigel Lawson, autore di An appeal to reason. A cool look at global warming, considera il discettare climatico una sostanziale invenzione... Antitesi totale?
Certo. La capacità di penetrazione degli scettici sulla pubblica opinione è enorme. L'1% degli scienziati non crede ai cambiamenti climatici, ma il 40% della popolazione è convinta che sia un tema che davvero divide la comunità scientifica.
C'è una giustificata tendenza alla rimozione. I temi climatici appaiono ai più incomprensibili e catastrofisti. È come se Martin Luther King avesse iniziato il suo più celebre discorso dicendo "Ho un incubo" invece di "un sogno", lo dice lei stesso...
Questo è quello che considero il "paradosso di Giddens" ed è il problema centrale del dibattito climatico. Per gli intellettuali è una sfida aperta. La crisi del credito è diventata tema di discussione in famiglia perché la bolla immobiliare tocca il portafoglio. Il cambiamento climatico, invece, è un tema politico che non ha precedenti nella storia perché narra di rischi astratti e futuri. Il cittadino comune ha difficoltà a stabilire una relazione fra questi scenari e l'urgenza della quotidianità e, così, il clima resta in fondo ai suoi pensieri. Diventerà una priorità solo quando il disastro sarà imminente. Un paradosso, appunto. La frase di Martin Luther King è esplicativa dell'approccio positivo che va dato al cambiamento ambientale. Ci vuole una visione forte della società prossima ventura, basata su quel capitalismo responsabile e pianificato di cui ho detto.
Visioni future, utopie, pensiero laterale: la comunicazione di messaggi del genere è impresa in verticale che mette alle corde il principio stesso di democrazia...
Tanti pensano che sia necessario un approccio dall'alto al basso che, cioè, per determinare una svolta nei comportamenti ci voglia davvero un atteggiamento autoritario. Non appartengo a quella scuola. La chiave è in tre passaggi. Prima di tutto, ritorno alla pianificazione politico-economica adottando una strategia simile a quella che si usa per organizzare la riforma del sistema pensionistico. In secondo luogo, si deve creare un'atmosfera sociale ed economica che agevoli la creatività, perché sono i salti tecnologici che determinano le vere svolte. In terzo luogo, dobbiamo sviluppare consenso politico trasversale. La questione climatica non sta né a destra né a sinistra, ma è vista come radicata a sinistra per gli atteggiamenti proto-rivoluzionari dei movimenti ecologisti. Il verde come il nuovo rosso è uno slogan da dimenticare.
12 giugno 2009
Padoa-Schioppa: "Il sogno
di una moneta mondiale"
di Alberto Orioli
Pagina: 1 2 3 di 3 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
10 giugno 2009
Regole e moneta. Da ex banchiere centrale Tommaso Padoa-Schioppa tiene uno sguardo "lungo" su entrambi questi capisaldi, i fondamenti dell'economia di mercato. "Lungo" giacché - come sostiene nel libro scritto con Beda Romano La veduta corta - è proprio la limitatezza dell'orizzonte - dei mercati, dei decisori politici, dei consumatori, degli azionisti - ad aver portato la situazione dov'è ora.
Cominciamo dall'euro. Con lo sguardo lungo dove lo vede?
Se la crisi portasse a un massiccio spostamento di composizione delle riserve e a un forte indebolimento del dollaro, l'euro si apprezzerebbe in misura eccessiva; per l'Europa sarebbe allora un problema, un grande problema.
Quindi la "lezione per il futuro" è una nuova moneta unica come chiedono i cinesi?
Non lo chiedono solo i cinesi. Ne parlano da tempo una delle menti economiche più acute della nostra epoca come Robert Mundell e un autorevolissimo ex banchiere centrale americano come Paul Volcker. Sono convinto che la Cina abbia sollevato un tema ormai maturo. Se poi lo ha fatto per interesse - come dice Paul Krugman - cioè perché ha accumulato troppi dollari, può essere. In ogni caso è una motivazione legittima, visto che non si può chiedere a Pechino di essere altruista quando tutti agiscono per interesse. Il punto, semmai, è comprendere quale sia la coincidenza tra ragion di stato cinese e interesse generale globale. In ogni caso, da ex banchiere centrale penso che quando si parla di standard globali, prima ancora che a quelli legali si debba guardare a quello monetario, che è un fatto economico funzionale, seppure vincolato a un substrato legale. Insomma, credo proprio che questa crisi ponga il problema di un nuovo standard monetario internazionale. La sua assenza e l'assenza della disciplina che esso imporrebbe sono una delle cause profonde della crisi attuale.
Prima c'era l'aggancio della moneta all'oro...
Se ci fosse stato ancora quell'aggancio, negli ultimi anni i paesi che accumulavano ingenti disavanzi esterni - come gli Stati Uniti - avrebbero dovuto convertirne una parte proprio in oro; la conseguente scarsità di riserve auree li avrebbe obbligati a correggere la rotta.
O a denunciare l'accordo, come fecero gli Usa che sganciarono il dollaro dal metallo giallo.
È vero, nel '71 gli Usa si sottrassero all'impegno. Per anni l'"aereo" del dollaro ha continuato a volare spinto dalla forza politica ed economica degli Stati Uniti. Ma non penso che, se si guarda al mondo di domani, quando ci saranno 4-5 o 6 colossi mondiali, questi potranno accettare che la moneta di uno solo di essi sia la moneta di tutti. Anche se il tema non è ancora iscritto all'ordine del giorno, quando si parla di standard internazionali penso si debba riflettere sulla moneta mondiale.
Ma come sarebbe il mondo con una sola moneta?
Non lo so, è un progetto su cui è urgente lavorare e pensare a fondo, e dubito che la soluzione sia una sola moneta. È diverso immaginare un oggetto che vola e inventare l'aeroplano. Oggi ne sappiamo abbastanza per dire che abbiamo bisogno di un oggetto che vola, di una misura comune che imponga disciplina al sistema monetario mondiale. Su scala mondiale non mi pare praticabile una soluzione tipo euro, fondata sul modello della moneta unica - un "globus" ad esempio - e della banca centrale unica. Vedo piuttosto una costruzione a due livelli: uno standard globale governato in comune e monete regionali con cambi non più interamente lasciati al mercato.
Chi ha ragione tra Krugman, che chiede più debito per uscire dalla crisi, e Ferguson, che mette in guardia dai pericoli dell'eccesso di debito che mina la stabilità dei governi?
Entrambi e, quando si danno torto l'un l'altro, nessuno dei due. Il fatto è che i rimedi - monetari e di bilancio - per combattere l'emergenza e quelli per impedire il ripetersi della crisi hanno segno opposto: espansivi gli uni, restrittivi gli altri. Come quando si somministra metadone a un tossicodipendente in cura.
Al G-8 l'Italia intende abbozzare i nuovi global legal standard per i mercati finanziari. Sarà - nelle intenzioni del Governo - un primo strumento per uscire dalla crisi e per evitarne altre.
Le determinanti profonde della crisi sono tre: l'illusione che i mercati si possano autoregolare; la contraddizione tra mercati globali e politiche rimaste nazionali; la veduta corta come criterio per le scelte, pubbliche e private. I global legal standard abbracciano i primi due temi e nascono dall'idea che il mercato abbia bisogno di regole e che le regole debbano essere internazionali. Ma il problema non finisce qui, qui incomincia: chi decide le regole? E che strumenti ha per farle rispettare? Si pone l'ardua questione di un potere di politica economica superiore.
Oggi quel potere non c'è.
No e sì. L'intero universo della cooperazione internazionale si è spostato negli anni verso azioni volontarie e non vincolanti, soprattutto da quando si è abbandonato il sistema di Bretton Woods che è un - sia pur debole - potere sovranazionale. Prima il G-5, poi il G-7 e il G-8 ora il G-20: sigle dietro cui non c'è alcuna realtà istituzionale, non trattati, non sistemi giuridici. Parlare in queste sedi di global legal standard significa fare menzione di qualcosa che per adesso manca di ogni infrastruttura giuridico-istituzionale.
In attesa di avere un modello diverso di governance globale, qual è la sede migliore dove ridisegnare le regole?
Una forte convergenza politica in seno al G-20 è un passaggio necessario ma non sufficiente per arrivare ai nuovi standard di cui parla il governo italiano. Quel passaggio deve portare a mutamenti sul piano del diritto e della distribuzione tra poteri nazionali e potere internazionale, mutamenti che sono impossibili al di fuori di una chiara architettura istituzionale e senza una base posta da trattati internazionali. A proposito di nuove regole vorrei però osservare che a mio parere non è stato un virus sconosciuto a provocare la crisi. Più spesso è stato un mancato rispetto di regole esistenti, sicché un'ordinaria profilassi sarebbe bastata a evitare le vicende più nefaste. Questo, i regolamentatori non lo ammettono volentieri.
Intanto se ne parlerà al G-8 di Lecce.
Sarà un primo esame. Sono stato nel G-20 fin dalla sua riunione costitutiva. Hai davvero la sensazione di vedere seduto al tavolo tutto il mondo, in una riunione sufficientemente ristretta per consentire un'efficace interazione tra i partecipanti. Le altre riunioni, con 200 paesi rappresentati, sono assemblee dove si fanno solo dichiarazioni e non c'è alcuna interazione tra partecipanti. E poi, grazie alla sua composizione, il G-20 tratta anche dei temi del commercio, che sono parte essenziale della cooperazione internazionale; il G-8 non lo poteva utilmente fare perché in questa materia gli interlocutori devono essere soprattutto i paesi emergenti o quelli a basso reddito. Infine, è positivo il fatto che al G-20 siedano ora i capi di stato o di governo, perché solo a quel livello è possibile una sintesi politica; i ministri delle finanze non hanno delega sufficiente.
Anche le decisioni del G-20 sono senza infrastruttura giuridica. Poi contano Fondo monetario, Banca mondiale e Wto.
Il G-20 dovrebbe trovare una forma di confluenza nelle istituzioni che ancora oggi costituiscono i pilastri della cooperazione internazionale multilaterale: Fmi, Banca mondiale, Wto e le stesse Nazioni Unite. Sono quanto di meglio ci abbia lasciato - dagli anni 40 - l'esperienza storica del XX secolo. Quando il cancelliere Angela Merkel propone un Consiglio di sicurezza dell'economia esprime proprio l'esigenza di far confluire le decisioni politiche del G-20 in istituzioni dotate di un'infrastruttura giuridica più solida dell'occasionale concorso di volontà che, in una sede di cooperazione volontaria, può sempre venire meno. Com'è noto, gli accordi del G-20 sono reversibili e vanno raggiunti con il benestare di tutti i partecipanti.
Torniamo alle regole. Quanto hanno influito sulla crisi i conflitti d'interessi tra regolatori e regolati, tra controllori e controllati?
Moltissimo. In questo caso le regole o non c'erano o erano troppo blande perché scritte da coloro ai quali si applicavano. Se i modelli interni su cui è basata la valutazione non sono rigorosi e l'autorità pubblica che li deve validare si fida troppo di come sono fatti o non li capisce, allora c'è un problema. Se a loro volta quei modelli sono appoggiati sulla valutazione (rating) di agenzie pagate da coloro stessi che emettono i titoli che esse devono giudicare, allora c'è un problema. Se le regole sui compensi dei manager sono fatte dagli stessi manager o approvate da comitati che non prendono le distanze dai soggetti di cui determinano i compensi, allora c'è un problema. Insomma, così tutto il sistema non ha timone.
Ed è qui che entra il tema dello sguardo corto?
Sì, tutte le anomalie descritte finora sono riconducibili alla tematica dell'accorciamento degli orizzonti temporali: le agenzie di rating invece di guardare avanti guardano al momentaneo umore del mercato; i compensi sono legati ai risultati ottenuti nel breve periodo; le politiche economiche sono agganciate alle scadenze elettorali che obbligano a tenere l'economia sempre in effervescenza. Se ci fosse qualcosa che semplicemente obbligasse, pur usando gli stessi parametri decisionali, a passare dalla lunghezza d'onda trimestrale a quella di uno o due lustri, tutto potrebbe rimanere uguale, ma tutto cambierebbe in meglio.
Oggi appare impossibile.
Me ne rendo ben conto. Eppure una presidenza come quella di Barack Obama è impegnata proprio in questa difficile arte di persuadere una nazione di quanto sia necessario allungare i tempi per uscire dalla crisi e per avere risultati durevoli. I sondaggi per ora lo confortano.
Il voto di domenica sembra dimostrare che in Europa ritrovano forza i gruppi nazionalistici o addirittura anti-europei. C'è il rischio di arroccamenti o di nuovi nazionalismi.
Purtroppo l'arroccamento è già in atto. Se è vero che l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende alla virtù, il fatto che ne vediamo molta in questi giorni nelle partite che riguardano banche e auto, i due settori finora più colpiti dalla crisi, ci dà la misura del vizio sottostante. Più si moltiplicano le dichiarazioni retoriche sulla cooperazione europea, meno c'è coesione europea.
Dunque un'Europa più piccola?
Credo che l'Europa sia su un crinale. È tirata da due forze opposte: quelle che vogliono aumentare la dose di unione e quelle che puntano alla rinazionalizzazione delle economie e delle politiche. La partita è aperta, anche se ora prevalgono le spinte disgregatrici. Sono convinto che la crisi porterà a un'Europa diversa da com'è ora, perché essa è troppo forte per lo stato attuale di semi-integrazione.
E l'Europa politica?
Quello che si poteva fare per l'unificazione che non fosse politico è stato fatto: ma fare un'Europa politica avrebbe un effetto economico formidabile e certo aiuterebbe anche ad uscire dalla crisi, perché consentirebbe di governare la politica economica in modo congiunto nuovo e unitario. Basterebbe riconoscere in un bilancio comune ciò che già è europeo (alcune infrastrutture, parte dell'energia, parte della difesa). In fin dei conti, il bilancio federale Usa all'inizio del XX secolo, cento anni dopo la nascita della Federazione americana, era pari a circa il 5% del Pil Usa. Bisognerebbe che anche i poteri nazionali accettassero la logica espressa in questi giorni da John Elkann, azionista di maggioranza della Fiat: accettare di diventare più piccoli in una realtà più grande. L'Europa che immagino è esattamente questo.
10 giugno 2009
Senza diritto, che mercato è
di Ugo Mattei
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
5 giugno 2009
Non avrebbe senso aggiungere la voce di un giurista al coro tanto affollato quanto tardivo degli economisti che spiegano la crisi. Del resto il giurista è figura tendenzialmente reattiva e interviene soltanto qualora richiesto di un parere legale ex ante o per cercare di rimediare ex post a un disastro avvenuto. In genere, ai clienti si raccomanda sempre d'interpellare il legale in anticipo, evitando conseguenze catastrofiche di scelte maldestre. A tal fine, la maggior parte dei sistemi giuridici diversi da quelli di common law hanno istituzionalizzato l'obbligo di coinvolgere ex ante un giurista professionista altamente qualificato, qualora l'operazione programmata rivesta importanza particolare. Da secoli nei paesi di tradizione romanista bisogna andare dal notaio per operazioni importanti quali una compravendita immobiliare, la costituzione di una società o quella di un'ipoteca.
Sarebbe stato quindi bene che gli economisti si fossero rivolti in anticipo a giuristi pratici, cercando di comprenderne le preoccupazioni e i modi di ragionare, piuttosto che crearsene alcuni a propria immagine e somiglianza com'è avvenuto con i cultori della cosiddetta law and economics (analisi economica del diritto) negli Stati Uniti. Ciò non è successo. Di conseguenza, l'idea che il diritto dovesse disciplinare e regolamentare i comportamenti di mercato, selezionando quelli ammissibili e vietando quelli inammissibili sulla base di un criterio estrinseco (giustizia, interesse pubblico, eccetera) rispetto alle esigenze del mercato stesso (efficienza economica, stimolo alla crescita, eccetera) è stata denigrata come obsoleta nei dipartimenti di economia e nelle law schools americane e anche sovente in Europa.
Mimic the market! (Imita il mercato!), è stata la parola d'ordine cui hanno ubbidito, quasi incantati dal prestigio dei cultori dell'economia i giuristi più "moderni", svolgendo conseguentemente il ruolo degli utili idioti per un progetto di deregolamentazione del mercato che, travolgendone le regole giuridiche più resistenti, non poteva che preludere alla catastrofe. Da Bruxelles, per esempio, in nome del mercato dei servizi giuridici, si è lanciata una crociata contro gli ordini professionali, cercando di consegnare anche in Europa il controllo di legalità nei trasferimenti immobiliari a compagnie di assicurazione e banche, come avviene rispettivamente negli Stati Uniti e in Inghilterra.
Sempre da Bruxelles e sempre in nome del diritto "market friendly" (ossia che non controlla ma stimola) si è sponsorizzato l'alleggerimento della corporate governance, imponendo riforme strutturali ai paesi membri volte a configurare organizzazioni economiche complesse e strutturatissime come meri "fasci di contratti" (nexus of contracts theory).
Potremmo moltiplicare gli esempi. Possiamo però osservare un'inversione di rotta, almeno in Europa. I giuristi sono stati finalmente chiamati in causa, e certo hanno qualcosa da dire se passa la tesi per cui nuove regole sono più importanti di iniezioni di cash nelle banche per uscire dalla crisi e recuperare perlomeno un orizzonte di medio periodo. Come noto, la presidenza italiana del G-8 ha incaricato un gruppo di giuristi presieduto da Guido Rossi di preparare una lista di legal standards per la finanza globale.
Ora, al di là del merito di un lavoro ancora largamente in fase di gestazione, il dato importante di questa scelta italiana è proprio quello di aver rivendicato il corretto rapporto fra diritto e mercato. In soldoni, l'idea dei legal standards restituisce vigore alla nozione, abbandonata nel ventennio neoliberista, per cui non è il diritto a dover essere giudicato in base alla sua coerenza con un'idea astratta di "mercato efficiente", ma che viceversa sono i concreti e diversi mercati a dover essere valutati a seconda della loro compatibilità con criteri giuridici che, in ultima analisi, sono il prodotto di scelte politiche.
In effetti, la rivoluzione culturale dell'analisi economica del diritto, trionfante anche in sede di policy making a partire dagli anni 80, era tutta qui. Per la prima volta nella storia, il diritto veniva visto come un sistema di incentivi e di prezzi impliciti per le azioni sociali. Una carota e non un bastone, sicché in nome dell'"efficienza" il cartello "sosta vietata" non significava più "non parcheggiare qui il tuo veicolo", ma piuttosto "parcheggia pure qui se sei disposto a pagare i 35 euro della multa per divieto di sosta". Questo è stato il passaggo culturale chiave che ha potuto trasformare il diritto in una qualsiasi commodity, oggetto delle regole del mercato e analizzabile con la modellistica di cui sono maestri gli economisti. Chiaramente il diritto, trasformato a immagine e somiglianza degli economisti, ha smesso di mordere almeno nei confronti di coloro che potevano produrre una domanda pagante di mercato.
La crisi richiede un'inversione di rotta e una capacità di restituire i denti alla giuridicità nei confronti delle forze economiche. Molti sostengono la necessità di costruire un ordine giuridico globale sovrano (cosa con ben scarse possibilità concrete a breve). Mi pare tuttavia che se si mette al centro l'enforcement (effettività) molto si può intanto fare anche in dimensione locale, facendo emergere un diritto vivente capace di contrastare gli abusi. Restituire i denti al diritto significa infatti armare le vittime attuali o potenziali dei disastri causati dalla speculazione finanziaria di sedi dove far valere i propri diritti, le proprie preoccupazioni e il proprio senso di giustizia.
Ciò può avvenire ex post, aprendo davvero all'attore civile le porte della giurisdizione sotto casa propria (domicilio dell'attore: Francia) attraverso sistemi avanzati e pubblici di access to justice, non solo class action ma anche il legal aid (Germania e Svezia), discovery effettiva e danni punitivi (Usa), eccetera. Ma soprattutto ciò deve avvenire ex ante garantendo controlli di legalità e piena comprensione delle operazioni economiche che vengono poste in essere. I gate keepers più sperimentati dalla storia sono i notai latini la cui assenza come controllori ex ante degli animal spirits è oggi rimpianta perfino nei sistemi di common law.
L'autore è professore di diritto comparato alla University of California, Hastings, e di diritto civile all'Università di Torino
Invia i tuoi commenti
5 giugno 2009
Main Street modello per l'Europa
di Marco Fortis
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
11 giugno 2009
ANIMAZIONE
La crisi della finanza e dell'economia, dai mutui subprime ai disoccupati
"È come se gli americani e i britannici avessero vissuto per un decennio in un paradiso di follia risparmiando meno di quanto avrebbero dovuto perché pensavano che i prezzi delle case e delle azioni sarebbero rimasti alti per sempre". Questa frase, che bene sintetizza una delle cause più profonde che hanno originato la crisi mondiale, non è di Carlo Azeglio Ciampi, che pure fu tra i primi a scrivere in un editoriale del 17 settembre scorso sul Messaggero che la politica espansiva americana aveva "drogato il mercato" e "trasferito al mondo intero una sensazione forte e non sana di euforia". Né si tratta di una battuta di Giulio Tremonti tratta dal suo libro premonitore La paura e la speranza o di una riflessione di Romano Prodi, oggi particolarmente impegnato a studiare le asimmetrie e gli squilibri della globalizzazione e della tecno-finanza non regolata. Né è un passaggio del volume della Fondazione Astrid a cura di Giuliano Amato, Governare l'economia globale. Nella crisi e oltre la crisi (aprile 2009). È invece un caustico giudizio dell'Economist (6 dicembre 2008).
Lo stesso Economist che nell'aprile 2006 però celebrava in modo inconsueto la Goldman Sachs, dedicandole addirittura una copertina e descrivendola come "una compagnia formidabile per il suo nuovo approccio al rischio". Lo stesso Economist che nel maggio 2005 metteva invece sulla copertina della sua edizione europea l'Italia sostenuta da tante piccole stampelle, descrivendo il nostro Paese come "the real sick man of Europe", a causa della sua bassa crescita economica dovuta a un'eccessiva vocazione manifatturiera, alla concorrenza asiatica e all'impossibilità delle nostre imprese di ricorrere, come in passato, alla svalutazione della lira.
Incoerenze e contraddizioni dunque non sono mancate. Tanto è vero che sempre l'Economist già nel giugno 2005 aveva sottolineato come l'impennata dei prezzi delle case in corso a livello mondiale fosse "la bolla più grande della storia", evidenziando come l'incremento del valore delle proprietà immobiliari nei paesi avanzati negli ultimi 5 anni fosse stato pari al 100% del Pil complessivo degli stessi (16 giugno 2005). Il che dimostra che alcune riviste, così come vari economisti, avevano intuito singoli pezzi del problema ma non le sue potenziali interconnessioni e dimensioni globali, che alla fine hanno portato alla più grave crisi economica dai tempi del 1929.
È indubbio che nell'ultimo decennio sia stata celebrata come "virtuosa" un tipo di crescita alquanto precaria e non sostenibile nel tempo. Basata, nel mondo avanzato, sul debito privato e sulla bolla immobiliare col sostegno dei risparmi dei paesi emergenti, come ha bene sottolineato su queste colonne Barry Eichengreen. Sicché i paesi "virtuosi" erano quelli il cui Pil cresceva di più a prescindere dal propellente con cui tale crescita veniva alimentata. Oggi è invece chiaro che quei Paesi, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Islanda ecc., sono finiti in un bel pasticcio e hanno originato con il loro indebitamento privato e i loro squilibri interni ed esteri la crisi mondiale stessa. Il debito delle famiglie americane e inglesi è oggi pari a circa il 100% dei Pil dei rispettivi paesi. In Irlanda ogni singolo abitante ha in media oltre 32mila euro di debiti soltanto per i mutui per la casa, in Islanda oltre 56mila.
Oggi i "real sick men of Europe", che abbisognerebbero di stampelle molto più robuste di quelle che nel 2005 l'Economist dedicò all'Italia, sono: la Gran Bretagna (con un deficit commerciale estero gigantesco, due delle sue maggiori banche nazionalizzate, un deficit/Pil previsto dalla Commissione europea al 13,8% l'anno prossimo e un calo dei consumi delle famiglie nel 2009 che sarà il doppio di quello italiano); l'Irlanda (con un calo del Pil nel 2009 del 9%, un sistema bancario anch'esso salvato dallo Stato e le finanze pubbliche dissestate); la Spagna (con un tasso di disoccupazione lanciato senza freni verso il 20% e una bilancia commerciale negativa pesante come quella britannica). Mentre la crisi finanziaria ha letteralmente stravolto i sistemi bancari dell'Olanda e del Belgio.
Quanto all'Italia, poiché in questi ultimi anni due soli parametri principali sono stati superficialmente utilizzati per misurare lo stato di salute delle economie, cioè la crescita del Pil e il livello del debito pubblico, il nostro paese non poteva certo ben figurare nelle classifiche internazionali tanto in voga. Eppure già una quindicina di anni fa Giorgio Fuà, nel suo lavoro Crescita economica, ci aveva messi in guardia dall'"insidia delle cifre", stimolando gli economisti a cercare indicatori più completi del Pil per quantificare lo sviluppo dei moderni sistemi economici.
L'Italia è entrata in questa crisi mondiale, che non ha in alcun modo contribuito a causare, con famiglie poco indebitate e banche più solide di quelle degli altri paesi. Ma anche con una forte economia non finanziaria, essendo l'unica nazione a collocarsi contemporaneamente al secondo posto in Europa in tutti i tre settori dell'economia "reale", industria, agricoltura e turismo, come evidenziato anche dall'ultimo rapporto congiunto di Symbola e Fondazione Edison.
La retorica del declino prevalente negli ultimi anni ha fatto sì che la colpa della bassa crescita del Pil del nostro paese fosse attribuita a una presunta scarsa competitività dell'industria italiana sui mercati internazionali. Ma questa tesi è assolutamente falsa. Infatti, secondo una nostra ricerca, la quota dell'Italia nell'export totale di manufatti non alimentari del G-6 non è mai stata tanto elevata quanto oggi negli ultimi 110 anni, toccando un massimo storico nel 2008, proprio all'inizio dell'attuale crisi economica mondiale, con un surplus con l'estero di 67 miliardi di euro. Anche il Trade Performance Index elaborato dall'Unctad/Wto, d'altronde, pone l'Italia al secondo posto assoluto per competitività nel commercio internazionale dietro la Germania. Dunque, mentre negli altri Paesi le economie si espandevano usando la leva del debito, nei laboriosi capannoni delle nostre fabbriche si compiva un altro miracolo italiano.
Taluni economisti "ultra-liberisti" ora evidenziano che i Pil dei paesi manifatturieri esportatori, cioè le "formiche" Giappone, Germania e Italia, caleranno di più nel 2009 dei Pil dei paesi "cicala", come Usa, Gran Bretagna e Spagna. Il che dimostrerebbe, a loro avviso, la superiorità del modello di sviluppo dei secondi rispetto ai primi. Un'altra falsità. Infatti, ciò sta avvenendo soltanto perché i secondi stanno facendo, fin che potranno, più spesa pubblica dei primi per arginare gli effetti della crisi e non perché siano più "sani".
Dunque l'Italia deve risolvere i suoi problemi strutturali di cui siamo ben consapevoli (a cominciare dal debito pubblico e dal divario Nord-Sud) ma non deve perdere la fiducia nel suo ruolo di potenza manifatturiera. Nonostante gli ammortizzatori sociali e le reti di solidarietà sul territorio, la crisi mondiale colpirà duramente anche il tessuto industriale italiano, perché i nostri paesi clienti, verso cui si dirigono le nostre esportazioni, sono in gravi difficoltà. Ma, quando tornerà la ripresa, ora che tutti i maggiori paesi sono indebitati a livello "aggregato" (pubblico e privato) in misura analoga o anche più dell'Italia, i reali differenziali di crescita verranno non più dall'aumento dei debiti bensì dalla competitività e dalla capacità innovativa dei sistemi produttivi.
L'autore è economista dell'Università Cattolica
11 giugno 2009
Battaglie tra economisti? Un déjà vu
di Robert Skidelsky
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
11 giugno 2009
La storia è ricca d'esempi di celebri battaglie intellettuali. Nelle scienze naturali queste disfide quasi sempre sono sfociate in vittorie definitive, con la buona scienza che ha scacciato la cattiva. È molto difficile oggi trovare un astronomo tolemaico o un sostenitore della teoria del flogisto sulla combustione. Nelle scienze sociali la situazione è diversa. Le battaglie furibonde non mancano, ma vittorie definitive non ce ne sono mai. Anzi, un tratto tipico delle scienze sociali sono le battaglie interminabili, con sconfitte temporanee a seguito delle quali le forze sconfitte serrano le fila e lanciano un nuovo attacco.
Che l'economia non sia una scienza naturale è evidente dagli scontri inconcludenti che ne hanno punteggiato la storia. Cento anni fa regnava incontrastata la teoria classica, quella che "dimostrava" che il libero mercato era in grado di autocorreggersi fino alla piena occupazione. O si aveva una situazione costante di piena occupazione oppure, in caso di shock esterno, si ritornava in tempi rapidi alla piena occupazione. L'unica cosa capace di turbare il funzionamento della mano invisibile del mercato era la mano visibile dell'interferenza dello Stato.
Poi arrivarono la Grande Depressione del 1929-1932 e John Maynard Keynes. Keynes "dimostrò" che i mercati non avevano alcuna propensione automatica alla piena occupazione. Questa incapacità della mano invisibile giustificava le politiche pubbliche per il mantenimento della piena occupazione.
Per trent'anni o giù di lì, il keynesianesimo l'ha fatta da padrone nel mondo della scienza economica (e della politica economica). Harvard regnava e Chicago era sparita dalla circolazione. Ma Chicago si stava solo leccando le ferite e negli anni 60 partì al contrattacco. La nuova offensiva era capitanata da Milton Friedman con una costellazione di brillanti e giovani discepoli al seguito. Quello che fecero fu riproporre la teoria classica. Le loro "prove" della capacità dei mercati di autocorreggersi istantaneamente o quasi fino alla piena occupazione erano tanto più straordinarie perché adesso venivano espresse ricorrendo a modelli matematici. La teoria delle aspettative adattative, la teoria delle aspettative razionali, la teoria dei cicli economici reali, la teoria del mercato efficiente: tutte uscite dalla catena di montaggio della scuola di Chicago, con premi Nobel per i loro ideatori.
Nessun politico capiva gli aspetti matematici delle teorie, ma il messaggio passò senza difficoltà: il mercato era buono, lo Stato cattivo. I keynesiani erano in rotta. Dopo Ronald Reagan e Margaret Thatcher, le politiche keynesiane di piena occupazione furono abbandonate e i mercati deregolamentati. Poi è arrivata la quasi-Grande Depressione dei nostri giorni e la battaglia è ricominciata.
I frequentatori della blogosfera sapranno che il principale oggetto del contendere in questo momento sono gli effetti dei piani di rilancio. I lettori del Financial Times avranno potuto farsi una vaga idea dell'intensità della battaglia nell'editoriale del 30 maggio a firma Niall Ferguson, intitolato "A history lesson for economists in thrall to Keynes" ("Una lezione di storia per gli economisti asserviti a Keynes"). Ferguson e Paul Krugman, economista ed editorialista del New York Times, avevano già incrociato le spade in un convegno pubblico a New York, il 30 aprile. Lo storico sosteneva che l'incremento del deficit di bilancio avrebbe spinto al rialzo i tassi d'interesse sul lungo termine, riducendo pertanto a zero l'effetto di stimolo: la spesa pubblica avrebbe semplicemente "estromesso" la spesa privata. Infuriato, Krugman ha replicato sul suo blog che Keynes aveva dimostrato che ciò poteva accadere solo in una situazione di piena occupazione: in presenza di risorse inutilizzate, il deficit di bilancio farebbe sì crescere i tassi d'interesse, ma al contempo farebbe espandere l'economia. Le ignoranti osservazioni del professor Ferguson non facevano altro che confermare che "viviamo in un'epoca buia per la macroeconomia, dove conoscenze acquisite a caro prezzo sono state semplicemente dimenticate".
Ma questo non è un dibattito tra economisti e storici. È una battaglia all'interno del mondo degli economisti, fra neoclassici e neokeynesiani. La cosa affascinante è che si tratta di una riedizione quasi esatta del dibattito tra Keynes e il Tesoro britannico nel 1929-1930. L'opinione del Tesoro allora era che la spesa pubblica, finanziata con i titoli di Stato, avrebbe ridotto in misura equivalente la spesa privata. Keynes replicava che se questo fosse stato vero, si sarebbe applicato a qualsiasi nuovo atto di spesa privata. "In breve, la convinzione fatalistica che non possa esserci più occupazione di quella che già c'è è assolutamente infondata".
In seguito il Tesoro ripiegò su una posizione più difendibile. Il pericolo di un incremento della spesa pubblica - passò a sostenere - non risiedeva nell'estromissione "fisica" di risorse, ma nell'estromissione "psicologica". Se si fosse cominciato a dubitare della solvibilità dello Stato - un timore che Krugman ha ammesso - l'effetto avrebbe potuto essere una fuga di capitali, che avrebbe reso più oneroso per lo Stato prendere soldi in prestito.
Siamo condannati a rimettere in scena periodicamente lo stesso dibattito? In questa discussione specifica sono dalla parte di Krugman, ma non penso che la posizione di Ferguson rappresenti un ritorno al flogisto dell'economia. Pensarla in questo modo equivarrebbe a trattare l'economia come una scienza naturale, cosa che Keynes si guardava bene dal fare, ritenendo che l'oggetto di studio dell'economia fosse fin troppo variabile nel tempo.
L'opinione di Keynes era che abbiamo bisogno di modelli economici diversi in momenti diversi. La bellezza della sua Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta stava nel fatto che era sufficientemente generale da essere adattabile a una varietà di modelli applicabili in condizioni diverse. I mercati potevano comportarsi nei modi indicati dalla teoria classica e neoclassica, ma non era inevitabile che andasse in questo modo. Pertanto, era importante prendere precauzioni contro un cattivo comportamento. La rivoluzione keynesiana non fu un trionfo della scienza buona sulla scienza cattiva, fu una vittoria del giudizio buono sul giudizio cattivo.
L'autore è Emeritus Professor di economia politica all'Università inglese di Warwick
(Traduzione di Fabio Galimberti)
11 giugno 2009
La crisi passerà, attenti alle scorciatoie
di Harold James
Pagina: 1 2 di 2 pagina successiva
commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci
5 giugno 2009
Senza diritto, che mercato è
di Ugo Mattei
DISCUSSIONE / I commenti dei lettori
Ogni volta che si parla di crisi economica, le analogie con la Grande Depressione sono sempre in agguato. Nel suo ultimo World economic outlook, l'Fmi esamina questa analogia in modo esplicito, in termini non soltanto di tracollo della fiducia finanziaria, ma anche di rapido declino degli scambi globali e dell'attività industriale. In generale, la storia sembra più utile della teoria economica per interpretare eventi straordinariamente sorprendenti e di per sé imprevedibili.
Quasi immancabilmente, ogni volta che si ricorre all'analogia con la Grande Depressione, come anno di riferimento si prende il 1929. Ma nella Grande Depressione si manifestarono due patologie diversissime, e ognuna delle due implicava diagnosi - e cure - diverse.
La prima e più famosa di queste due patologie fu il crack azionario dell'ottobre 1929 negli Stati Uniti. Nessun altro paese conobbe un panico borsistico di simili proporzioni, in buona parte perché nessun paese aveva vissuto quell'euforica corsa al rialzo dei prezzi delle azioni che aveva indotto tantissimi americani, delle estrazioni più varie, a lanciarsi nella speculazione finanziaria.
La seconda patologia fu l'evento decisivo che trasformò una brutta recessione nella Grande Depressione. Una serie di crisi di panico del settore bancario nell'estate del 1931 si propagò dall'Europa Centrale, diffondendo il contagio finanziario prima alla Gran Bretagna, poi agli Stati Uniti e alla Francia, e infine a tutto il mondo.
Il panico del 1929 ha sempre avuto un ruolo preponderante nell'analisi della Grande Depressione per due ragioni abbastanza peculiari. Innanzitutto, nessuno è mai stato in grado di fornire una spiegazione soddisfacente del crollo della Borsa nell'ottobre del 1929, nel senso di una causa razionale, con gli operatori di mercato che reagiscono a una notizia specifica. Quel crack borsistico dunque rappresenta un dilemma intellettuale e gli economisti possono sperare di farsi una reputazione cercando di trovare una spiegazione innovativa a quegli eventi.
Certi sono arrivati alla conclusione che i mercati, semplicemente, sono irrazionali. Altri si sforzano di realizzare complicati modelli, secondo cui gli investitori forse erano riusciti a prevedere la Depressione, oppure avevano valutato l'eventualità di misure protezionistiche in altri paesi in risposta alla legge americana sui dazi doganali, anche se quella legge non era ancora stata approvata.
La seconda ragione della popolarità del 1929 tra studiosi e commentatori politici è che fornisce un motivo chiaro per intraprendere misure specifiche. I keynesiani sono riusciti a dimostrare che le misure di stimolo sono in grado di stabilizzare le aspettative del mercato, garantendo in questo modo un quadro di fiducia generale. I monetaristi raccontano una storia diversa ma parallela, e cioè che una crescita monetaria stabile previene perturbazioni drammatiche.
Il crack del 1929 non ebbe nessuna causa evidente, ma due soluzioni molto plausibili. Il disastro bancario europeo del 1931 fu esattamente il contrario. Nessun economista può sperare di costruire la sua carriera accademica trovando una spiegazione innovativa delle sue cause: il tracollo fu il risultato della debolezza finanziaria di paesi vittime, a causa di politiche sbagliate, di un'iperinflazione che aveva messo in ginocchio i bilanci delle banche. La vulnerabilità intrinseca accresceva il rischio di traumi politici, e le diatribe su un'unione doganale dell'Europa Centrale e sulle riparazioni di guerra bastarono a far crollare il castello di carte.
Ma riparare i danni non era semplice. A differenza del 1929, non esistevano (e non esistono oggi) risposte macroeconomiche evidenti ai problemi finanziari.
Alcuni macroeconomisti famosi, tra cui Larry Summers, che attualmente è il capo dei cervelli economici a disposizione dell'amministrazione Obama, hanno cercato di sminuire il ruolo dell'instabilità del settore finanziario come causa delle depressioni. Le risposte, se esistono, risiedono in un lento e sofferto repulisti dei bilanci e nella ristrutturazione microeconomica, che non può semplicemente essere imposta dall'alto per mano di un pianificatore onnisciente, ma esige un cambiamento di mentalità e di comportamento da parte di molte imprese e individui. Migliorare il sistema di regolamentazione e supervisione è una buona idea, ma serve più a evitare crisi future che a gestire le conseguenze di una catastrofe già avvenuta.
La conseguenza della lunga discussione accademica e popolare sulla crisi del 1929 è che la gente col tempo si è convinta che risposte facili esistono. Ma il crollo della Lehman Brothers nel settembre del 2008 è stato un evento simile al 1931, un evento che ricorda da vicino il mondo della Grande Depressione. I fallimenti delle banche austriache e tedesche non avrebbero trascinato il mondo intero dalla recessione alla depressione se quei Paesi non fossero stati altro che economie isolate o autosufficienti. Ma nella seconda metà degli anni 20 quei Paesi avevano costruito le loro economie su denaro preso in prestito (prevalentemente dall'America).
Quella dipendenza presenta diverse analogie con ciò che si è verificato negli Stati Uniti in questo decennio, con l'afflusso di denaro dalle economie emergenti, soprattutto asiatiche: un apparente miracolo economico che si basava in realtà sulla disponibilità dei cinesi a prestare soldi all'America. I fallimenti bancari del 1931, e del settembre 2008, hanno scosso la fiducia del creditore internazionale: allora gli Stati Uniti, oggi la Cina.
Entrambe le lezioni - quella sulla lentezza e la difficoltà della ricostruzione del settore bancario e quella sulla dipendenza da un grande fornitore esterno di capitali - sono sgradevoli. Per lungo tempo è stato molto più facile ripetere il mantra rassicurante di una comunità mondiale che aveva imparato, nel suo insieme, come evitare un tracollo in stile 1929, e che le Banche centrali di tutto il mondo lo avevano chiaramente dimostrato in occasione di crisi come quella del 1987 o quella del 2001.
I governi indubbiamente meritano elogi per aver stabilizzato le aspettative, e dunque per aver impedito che la crisi si aggravasse. Ma quando i governanti spacciano proposte politiche semplici, se non proprio semplicistiche, come fondamento della speranza di poter evitare un lungo periodo di difficili aggiustamenti economici, questo è fuorviante.
L'autore è professore di storia e affari internazionali alla Princeton
Copyright: Project Syndicate, 2009
(Traduzione di Fabio Galimberti)
Invia i tuoi commenti
5 giugno 2009
|